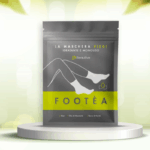In Italia, i disturbi del comportamento alimentare rappresentano un problema in crescita, coinvolgendo un numero sempre più alto di persone di tutte le età e con un notevole impatto sulla salute pubblica. L’attenzione mediatica si concentra spesso sull’anoressia, che rimane una delle forme più note e frequentemente riconosciute, ma il disturbo alimentare più diffuso e insidioso è un altro, spesso meno compreso e diagnosticato: il disturbo da alimentazione incontrollata, noto anche come binge eating disorder.
Il disturbo alimentare più diffuso: cos’è il binge eating
Il binge eating disorder ha oramai superato per incidenza sia l’anoressia che la bulimia, anche se resta ancora poco riconosciuto nell’immaginario comune. Si distingue per episodi ricorrenti in cui la persona consuma grandi quantità di cibo in un breve arco di tempo, accompagnati da una sensazione di perdita di controllo sul comportamento alimentare. A differenza della bulimia, questi episodi non sono seguiti da strategie compensatorie regolari, come il vomito autoindotto o l’uso di lassativi, il che rende il binge eating particolarmente pericoloso anche sul fronte delle complicanze fisiche, tra cui obesità e malattie metaboliche.
Il binge eating colpisce senza apparenti distinzioni di età, sesso o status sociale, anche se gli studi riportano una prevalenza leggermente superiore tra le donne. Spesso l’esordio si situa dall’adolescenza all’età adulta, ma le recenti statistiche mostrano un aumento di casi anche nei bambini e negli adolescenti, a causa di una combinazione di fattori psicologici, sociali e ambientali che accelerano l’insorgenza di queste problematiche.
Numeri allarmanti e dati epidemiologici
Negli ultimi anni, i dati epidemiologici hanno evidenziato una crescita continua dei disturbi alimentari, creando un’emergenza sanitaria riconosciuta anche dalle istituzioni. Secondo l’Istituto Superiore di Sanità e altre fonti autorevoli, in Italia oltre 3 milioni di persone convivono oggi con un disturbo alimentare, con una prevalenza stimata intorno al 6% della popolazione nazionale. Il binge eating si conferma il disturbo più frequente, con un’incidenza superiore sia rispetto all’anoressia che alla bulimia, come indicano le statistiche più aggiornate provenienti da ospedali e centri specialistici.
La situazione risulta ancora più preoccupante se si considera l’abbassamento dell’età di insorgenza. Oggi, bambini anche di 6-8 anni ricevono diagnosi di disturbi alimentari, un dato che mette in luce la necessità di interventi precoci e la crescente complessità di questi disturbi nell’era digitale, dove i social network e la pressione estetica giocano un ruolo non trascurabile nel plasmare la percezione di sé e del corpo.
Nonostante i numeri crescano anche tra gli uomini, con una quota del 20% dei casi nella fascia di età 12-17 anni, la prevalenza resta maggiore tra le donne, con l’80-90% dei casi totali. Questi dati sottolineano l’urgenza di affrontare la questione con approcci multidisciplinari, incentrati sia sull’aspetto clinico sia su quello preventivo.
Conseguenze fisiche e psicologiche
Il binge eating può portare a gravi ripercussioni fisiche, innanzitutto l’aumento di peso, spesso seguito dallo sviluppo di obesità e da una serie di complicanze metaboliche, cardiovascolari e articolari. Queste condizioni, unite al senso di colpa e vergogna che spesso accompagnano gli episodi di abbuffata, favoriscono l’innescarsi di un circolo vizioso che peggiora ulteriormente il quadro psicologico. L’isolamento sociale, la depressione e l’ansia sono spesso compagni silenziosi delle persone che vivono questo disturbo, rendendo difficile chiedere aiuto e uscire dalla spirale autodistruttiva.
L’aspetto silenzioso del binge eating sta proprio nel suo passare inosservato per molto tempo, sia agli occhi di chi ne soffre che delle persone vicine. Molte persone infatti faticano a riconoscere il proprio comportamento come patologico, attribuendo le abbuffate a semplice golosità o “debolezza” di volontà, trascurando l’elemento centrale della perdita di controllo e la componente compulsiva che caratterizza questo disturbo.
Principali segnali da non sottovalutare
- Episodi ricorrenti di abbuffate alimentari senza atti compensatori
- Sensazione di perdita di controllo durante l’abbuffata
- Mangiare anche in assenza di fame fisica, spesso in solitudine
- Sentimenti di colpa, disgusto o vergogna dopo la crisi
- Fluttuazioni significative di peso
- Progressivo isolamento sociale
Le cause: una rete complessa di fattori
Come molti disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, i meccanismi all’origine del binge eating sono complessi e coinvolgono una combinazione di fattori genetici, psicologici, ambientali e socio-culturali. Eventi traumatici nell’infanzia, difficoltà nelle relazioni familiari, stress, ansia e bassa autostima sono alcuni degli elementi che possono agire da fattori scatenanti o predisponenti.
L’avvento dei nuovi mezzi di comunicazione e la diffusione di modelli estetici irraggiungibili tramite social network contribuiscono ad aumentare la vulnerabilità delle giovani generazioni. A ciò si aggiunge la persistenza di pregiudizi e stereotipi legati al peso corporeo, che favoriscono la stigmatizzazione sociale e la tendenza a vivere il problema in solitudine, ritardando l’accesso a cure adeguate.
Il ruolo della famiglia e della società
La famiglia riveste un ruolo centrale tanto nella prevenzione quanto nell’intercettazione precoce dei segnali d’allarme. Un ambiente familiare supportivo, attento ai bisogni emotivi dei figli e capace di promuovere un rapporto equilibrato con il cibo rappresenta una protezione importante. Parallelamente, la società nel suo complesso è chiamata a contrastare i messaggi tossici veicolati dai media e a ridurre le pressioni legate all’aspetto fisico, promuovendo la diversità e l’accoglienza dei corpi in tutte le loro forme.
Diagnosi, cura e prevenzione
La diagnosi del binge eating disorder si basa sull’osservazione clinica e su criteri codificati nei manuali psichiatrici internazionali. Il trattamento più efficace si fonda su interventi multidisciplinari, che comprendono il supporto psicoterapeutico, spesso di tipo cognitivo-comportamentale, la consulenza nutrizionale, l’eventuale uso di farmaci e il coinvolgimento della famiglia. Negli ultimi anni, si riscontra una crescente attenzione verso la prevenzione grazie a campagne di sensibilizzazione e programmi educativi nelle scuole.
Un aspetto centrale nella prevenzione consiste nell’educare i più giovani a riconoscere i segnali precoci e ad avere un rapporto equilibrato con il cibo e con il proprio corpo, superando il mito della perfezione estetica e valorizzando invece il benessere psicofisico complessivo. Oltre alle istituzioni, è importante il contributo dei media e delle piattaforme social, chiamate a promuovere messaggi positivi e inclusivi contro ogni forma di discriminazione.
Infine, per chi soffre o crede di soffrire di un disturbo alimentare, chiedere aiuto è un atto di coraggio e il primo passo verso la guarigione. Le strutture pubbliche e private, unitamente alle associazioni di settore, mettono a disposizione risorse, professionisti e sportelli di ascolto anche anonimi, per garantire un percorso di cura efficace e rispettoso della dignità della persona.
La conoscenza, la comprensione e la sensibilizzazione rappresentano le principali armi per arginare il fenomeno dei disturbi alimentari. Solo contrastando l’ignoranza e i pregiudizi si può costruire una società più attenta e capace di prendersi cura dei propri membri più fragili, riconoscendo il diritto di ogni individuo a vivere in armonia con il proprio corpo e con la propria mente.