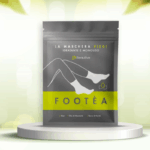Il bruciore retrosternale, accompagnato da tosse e dolore al petto, rappresenta una triade sintomatologica che spesso viene sottovalutata, ma che può invece indicare la presenza di un esofago infiammato, condizione più comunemente nota come esofagite. La frequenza di questi sintomi, la loro intensità e la persistenza nel tempo richiedono un’attenta valutazione clinica per escludere altre cause potenzialmente gravi, come patologie cardiache, ma soprattutto per intervenire tempestivamente sull’origine gastroenterologica.
Comprendere l’esofago infiammato: cause e fattori di rischio
L’infiammazione dell’esofago si sviluppa principalmente a seguito del reflusso gastroesofageo, una condizione in cui i succhi gastrici risalgono inesorabilmente verso l’alto, a contatto con la mucosa esofagea, provocando erosioni e lesioni. Oltre al reflusso, possono contribuire all’insorgenza di esofagite altre cause:
- Infezioni (batteriche, virali o fungine, in particolare da candida nei soggetti immunocompromessi)
- Reazioni allergiche (come nell’esofagite eosinofila)
- Uso prolungato di alcuni farmaci (antinfiammatori non steroidei, antibiotici, bifosfonati)
- Consumo eccessivo di alcol e fumo
- Interventi chirurgici o trattamenti radioterapici nell’area toracica
Tra i principali fattori di rischio spiccano il sovrappeso, un’alimentazione ricca di cibi grassi e acidi, l’uso di farmaci gastrolesivi e uno stile di vita sedentario, senza dimenticare predisposizioni anatomiche come l’ernia iatale.
Sintomi tipici e manifestazioni associate
Il bruciore al petto costituisce il sintomo chiave dell’infiammazione esofagea da reflusso e si localizza tipicamente dietro lo sterno, peggiorando dopo i pasti, durante la notte o in posizione sdraiata. Spesso si associa a:
- Tosse secca e stizzosa, frequente nelle ore notturne, talvolta scambiata per un disturbo delle vie respiratorie
- Dolore toracico, che può simulare un attacco cardiaco e talvolta essere percepito come irradiato alle spalle o alla gola
- Rigurgito di cibi o liquidi amari e acidi fino alla bocca
- Nausea, senso di peso allo stomaco e gonfiore
- Sensazione di nodo alla gola o difficoltà nella deglutizione (disfagia)
Più raramente, soprattutto nei casi avanzati o complicati, possono manifestarsi:
- Restringimento cronico dell’esofago (stenosi)
- Sanguinamento esofageo (presenza di sangue nel vomito o nelle feci)
- Mancanza di appetito e perdita di peso involontaria
Complicanze, diagnosi differenziale ed esami necessari
Una esofagite non trattata può evolvere con il tempo verso complicazioni, la più nota delle quali è l’esofago di Barrett, condizione in cui il rivestimento interno dell’esofago modifica la propria struttura a causa dell’aggressione acida cronica, aumentando il rischio di sviluppare neoplasie. Per questo motivo è essenziale escludere tempestivamente altre patologie più gravi, come le malattie cardiache e i tumori dell’esofago, attraverso una corretta diagnosi differenziale.
Gli strumenti diagnostici più utilizzati comprendono:
- Gastroscopia (endoscopia digestiva), che permette la visione diretta delle lesioni e l’eventuale esecuzione di biopsie
- pH-metria delle 24 ore per monitorare i livelli acidi esofagei
- Radiografie con mezzo di contrasto per valutare le alterazioni anatomiche
- Esami ematochimici in caso di sintomi sistemici o sospetto di infezione
Solo tramite un esame accurato è possibile distinguere tra una comune esofagite da reflusso, una forma allergica, infettiva o un disturbo di altra natura, come l’angina pectoris, che condivide con l’esofagite il dolore al petto.
Trattamento e prevenzione dell’esofagite
L’approccio terapeutico si basa in primo luogo sulla modifica dello stile di vita e sull’adozione di una dieta adeguata. È fondamentale identificare e ridurre i fattori scatenanti:
- Evitare pasti abbondanti, cibi grassi o acidi (agrumi, pomodoro, cioccolato, alcol e caffè)
- Non coricarsi subito dopo mangiato
- Sollevare la testata del letto per ridurre il reflusso notturno
- Ridurre il peso corporeo, smettere di fumare e limitare il consumo di alcolici
Dal punto di vista farmacologico, il trattamento si avvale di:
- Inibitori della pompa protonica (PPI), che riducono la produzione di acido gastrico
- Antiacidi per tamponare l’acidità nei momenti di maggiore fastidio
- Procinètici per facilitare il transito gastrointestinale
- Antibiotici o antimicotici in caso di esofagite infettiva
- Cortisonici sistemici in forme su base allergica (esofagite eosinofila)
Nei casi refrattari o in presenza di gravi complicanze, il ricorso alla chirurgia antireflusso può essere valutato. È importante eseguire controlli regolari, soprattutto se persiste la sintomatologia o se vi sono fattori di rischio.
Quando preoccuparsi e consultare uno specialista
La presenza simultanea di bruciore persistente, tosse cronica e dolore toracico che non regredisce con i comuni rimedi, specie se associata a difficoltà nel deglutire, perdita di peso o comparsa di sangue nel vomito o nelle feci, impone una valutazione specialistica urgente. È altrettanto essenziale non sottovalutare il dolore toracico, poiché potrebbe nascondere un infarto miocardico o altre emergenze mediche, soprattutto se associato a sudorazione, senso di oppressione e irradiazione al braccio o alla mandibola.
Distingue questa problematica anche la sua frequente cronicità: la recidiva dei sintomi dopo sospensione della terapia o la necessità di terapie ripetute richiedono un monitoraggio rigoroso per prevenire complicanze irreversibili.
Conoscere i campanelli d’allarme associati all’infiammazione esofagea consente così di intervenire tempestivamente, migliorando la qualità della vita e prevenendo rischi futuri. Per approfondire le nozioni legate a questa condizione, si può fare riferimento al concetto di reflusso gastroesofageo, elemento centrale nella maggior parte delle manifestazioni cliniche trattate.